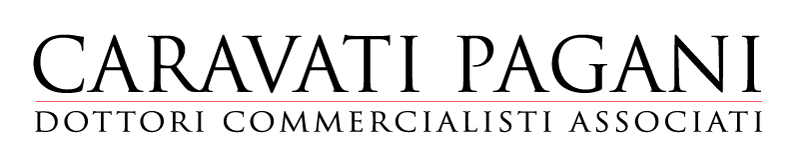Il termine whistleblowing, ormai consolidato anche nel lessico giuridico italiano, indica l’atto con cui un soggetto interno a un’organizzazione pubblica o privata segnala in via riservata comportamenti illeciti, irregolarità gravi o violazioni di norme che si verificano nel contesto lavorativo. Il segnalante, detto anche whistleblower, assume un ruolo chiave nella prevenzione e nell’emersione di illeciti, poiché contribuisce al buon funzionamento delle istituzioni e alla compliance aziendale. Di seguito esaminiamo in che modo la legge tutela il whistleblower.

1. WHISTLEBLOWING, COS’È DAL PUNTO DI VISTA LEGALE ↑
In Italia, il quadro normativo si è sviluppato in due tappe fondamentali:
- la Legge 179/2017, che ha introdotto specifiche tutele per i whistleblower nei settori pubblico e privato;
- il D.Lgs. 24/2023, che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937, fissando standard minimi comuni per la protezione dei segnalanti nei Paesi membri. Quest’ultima rappresenta un passaggio determinante infatti ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione e ha introdotto obblighi precisi per le imprese con più di 50 dipendenti, tra cui l’istituzione di canali di segnalazione interna.
La normativa punta a garantire sia la riservatezza del segnalante che la sua protezione da ritorsioni, in una logica di deterrenza sistemica. Tuttavia, pur trattandosi di un presidio importante, il whistleblowing presenta limiti applicativi e criticità interpretative che rendono necessaria una lettura attenta delle norme e della giurisprudenza, specie con riferimento all’intersezione tra tutela del lavoratore e legittimità dei provvedimenti datoriali.
2. LE TUTELE DEL WHISTLEBLOWER NEL RAPPORTO DI LAVORO ↑
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023, il sistema italiano di tutela del whistleblower ha subito una profonda evoluzione, ponendo in particolare l’accento sulla dimensione lavoristica della protezione. Il decreto stabilisce che la tutela contro le ritorsioni scatta solo se il segnalante aveva ragionevoli motivi per ritenere veritiere le informazioni comunicate (art. 16). Non è quindi sufficiente una segnalazione generica o priva di fondamento ma è necessario che la denuncia risponda a criteri di buona fede e plausibilità. In caso di ritorsione, l’onere della prova viene invertito (art. 17) ed è il datore di lavoro a dover dimostrare che il provvedimento adottato (licenziamento, demansionamento, trasferimento o altro) non è collegato alla segnalazione. Si tratta di un caposaldo della disciplina, che trova conferma nella recente giurisprudenza di legittimità. Secondo la Cassazione n. 17266/2024, affinché un licenziamento possa dirsi illegittimo per ritorsione, occorre che l’intento ritorsivo sia l’unica ragione del provvedimento. Inoltre, deve sussistere una connessione temporale tra la segnalazione e l’atto impugnato.
La disciplina non si traduce tuttavia in una protezione assoluta e l’inversione dell’onere della prova non può comprimere il diritto di difesa del datore di lavoro, garantito dall’art. 24 della Costituzione. L’equilibrio tra tutela del whistleblower e salvaguardia della prerogativa datoriale rappresenta il cuore del sistema ma costituisce al contempo uno dei suoi limiti strutturali, specialmente nei contesti aziendali complessi in cui le decisioni hanno spesso una molteplicità di cause.
3. WHISTLEBLOWING LIMITI E POSSIBILI ABUSI ↑
Uno dei principali limiti del whistleblowing emerge dal possibile uso distorto dello strumento da parte del segnalante, che potrebbe sfruttare la protezione offerta dalla legge per perseguire interessi personali o per danneggiare colleghi e superiori. Questo rischio è stato più volte evidenziato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza. In particolare, la Corte di Cassazione (sent. 27 giugno 2024, n. 17715) ha chiarito che la tutela non si estende a chi effettua la segnalazione con finalità ritorsive o di vantaggio personale. Se il comportamento del dipendente è orientato a screditare altri o a ottenere benefici professionali, la denuncia perde legittimità e può diventare oggetto di sanzione disciplinare. In altre parole, la buona fede deve rappresentare il motore della segnalazione. Il semplice fatto di inoltrare una denuncia non garantisce immunità ed è necessaria una stretta correlazione tra condotta e finalità di tutela dell’interesse pubblico. Lo stesso principio è stato ribadito dal Consiglio di Stato (sent. 17 luglio 2023, n. 7002), che ha precisato come le segnalazioni prive di fondamento o motivate da dissidi interni non possano beneficiare delle tutele previste dalla normativa. Si tratta di un tema di grande importanza per il mondo delle imprese, le quali devono adottare policy interne in grado di distinguere tra segnalazioni genuine e strumentali. Ciò al fine di evitare che l’istituto del whistleblowing venga percepito come una leva impropria di pressione o di conflitto all’interno dell’organizzazione.
4. ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI SUI CONFINI DEL WHISTLEBLOWING ↑
Il perimetro applicativo del whistleblowing è stato ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza recente, che ha fornito importanti indicazioni circa i comportamenti che esulano dalle tutele previste dalla legge. Emblematico è il caso esaminato dalla Cassazione (sent. 17715/2024), relativo a una dipendente che, pur operando in ambito pubblico, ha registrato senza consenso una conversazione con un docente e ha successivamente pubblicato l’audio su Facebook. La Corte ha escluso che una simile condotta potesse rientrare nel perimetro del whistleblowing. La diffusione pubblica del contenuto ha aggravato l’illecito, rendendo evidente la finalità extra-giurisdizionale del gesto. Secondo la Cassazione, la registrazione occulta può considerarsi legittima solo se strettamente finalizzata alla tutela dei propri diritti in giudizio, non per alimentare controversie personali o generare clamore mediatico. Lo stesso principio è stato confermato dalla Cassazione n. 1880/2025 e dal Consiglio di Stato (sent. 6 dicembre 2021, n. 8150), che hanno escluso la possibilità di ricondurre lamentele soggettive o problematiche relazionali all’interno dello strumento del whistleblowing. Le segnalazioni devono essere circostanziate, documentate e riferite a condotte illecite rilevanti per la collettività. Inoltre, l’uso distorto dell’istituto può giustificare provvedimenti organizzativi, come il trasferimento per incompatibilità ambientale, con l’obiettivo di tutelare il contesto lavorativo e l’equilibrio relazionale tra le parti.
5. VALUTAZIONE CONCRETA E CORRETTA APPLICAZIONE DELL’ISTITUTO ↑
Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale, emerge con chiarezza che il whistleblowing è uno strumento di tutela a forte valenza sistemica ma che richiede un’applicazione attenta, rigorosa e contestualizzata. La protezione offerta al segnalante non può trasformarsi in una garanzia incondizionata. Affinché il soggetto possa beneficiare delle tutele, è necessario che rientri nell’ambito soggettivo definito dalla legge e che la segnalazione rispetti i criteri di fondatezza, pertinenza e buona fede. Nei casi in cui insorgano contenziosi, sarà compito del giudice valutare se la misura adottata dal datore di lavoro costituisca ritorsione o semplice illegittimità per altri motivi. Si pensi ad esempio alla sentenza del Tribunale di Bergamo (n. 2/2022) che ha annullato un licenziamento non per il carattere ritorsivo del provvedimento, bensì per l’assenza del fatto materiale su cui si fondava.
L’adozione di procedure interne chiare, audit periodici e una cultura della segnalazione etica sono elementi imprescindibili per garantire l’efficacia del sistema. Le imprese dovrebbero affiancare ai canali di segnalazione strumenti di formazione e policy trasparenti. Solo in questo modo il whistleblowing può diventare un vero strumento di prevenzione e non un’arma a doppio taglio.